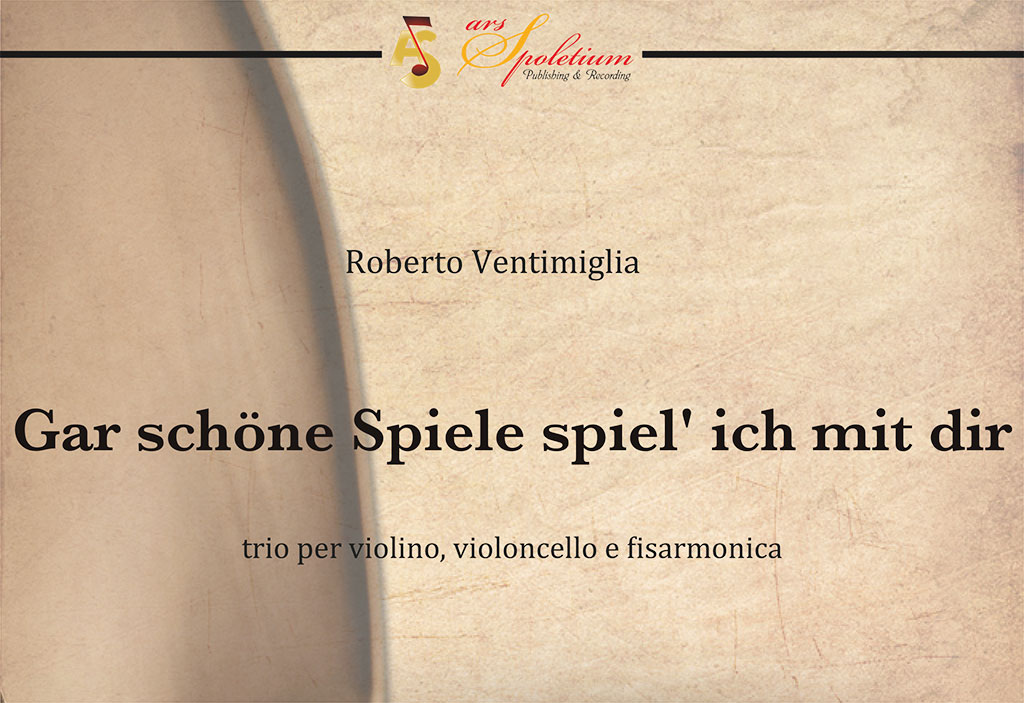Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir – Il nuovo trio per fisarmonica, violino, e violoncello di Roberto Ventimiglia
Continua il nostro viaggio all’interno del doppio CD Accordion Waves suona italiano, stavolta alla scoperta del brano Gar schöne Spiele spiel’ich mit dir, per fisarmonica, violino e violoncello di Roberto Ventimiglia.
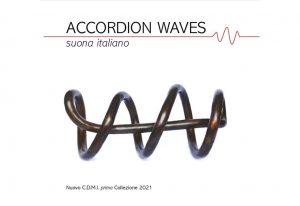 Nato nel 1982, studia composizione al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina con Paolo Rotili e Alberto Meoli, diplomandosi con lode. Un costante confronto dialogico con la tradizione, pur nell’attenzione ai linguaggi della contemporaneità, è alla base del suo lavoro sia in Conservatorio che dopo, quando si perfeziona con Alessandro Solbiati e Salvatore Sciarrino. Questo confronto attivo lo ha visto, tra l’altro, vincitore del Premio Nazionale delle Arti Miur-Afam 2013 con un brano per flauto ed elettronica su supporto fisso, e finalista al concorso di composizione In Clausura 2014 con uno scherzo per cento violoncelli diretto da Giovanni Sollima. Roberto Ventimiglia ha studiato anche musicologia presso l’università di Tor Vergata (Roma) con Giorgio Sanguinetti, Agostino Ziino, Giorgio Nottoli, Gino Stefani e Giorgio Adamo.
Nato nel 1982, studia composizione al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina con Paolo Rotili e Alberto Meoli, diplomandosi con lode. Un costante confronto dialogico con la tradizione, pur nell’attenzione ai linguaggi della contemporaneità, è alla base del suo lavoro sia in Conservatorio che dopo, quando si perfeziona con Alessandro Solbiati e Salvatore Sciarrino. Questo confronto attivo lo ha visto, tra l’altro, vincitore del Premio Nazionale delle Arti Miur-Afam 2013 con un brano per flauto ed elettronica su supporto fisso, e finalista al concorso di composizione In Clausura 2014 con uno scherzo per cento violoncelli diretto da Giovanni Sollima. Roberto Ventimiglia ha studiato anche musicologia presso l’università di Tor Vergata (Roma) con Giorgio Sanguinetti, Agostino Ziino, Giorgio Nottoli, Gino Stefani e Giorgio Adamo.
In seno a queste premesse nasce il brano Gar schöne Spiele spiel’ich mit dir, da me inciso per Ars Spoletium insieme al violino di Stefano Zompi e al violoncello di Mattia Geracitano.
Iniziamo dal principio: il brano è strettamente imparentato con un lied di Schubert, l’Erlkönig, scritto nel 1815 su testo di Goethe. Viene narrata la storia di un padre che, nel cuore della notte, corre a cavallo con il figlio malato alla disperata ricerca di un medico; nel delirio febbricitante il bambino ha l’illusione di sentire la voce tentatoria del Re degli Elfi (in tedesco Erlkönig, appunto), che gli prospetta la possibilità di fare “tanti bei giochi” (gli schöne Spiele del titolo). Questi personaggi (il padre, il Re degli Elfi, e il bambino delirante), uniti al tema che potremmo definire quasi madrigalistico del galoppo del cavallo, realizzato attraverso l’ossessività delle terzine, sono chiaramente distinti nell’originale schubertiano, mentre nel brano di Roberto Ventimiglia questi elementi vengono mescolati, scomposti, e ricomposti, a formare una nuova trama in cui gli strumenti si contendono le varie parti senza soluzione di continuità fino alla conclusione, improvvisa e quasi sorprendente.
Non si pensi tuttavia a una semplice “redistribuzione” in senso combinatorio degli elementi: il brano di Ventimiglia prende sì le mosse da quello di Schubert (e in effetti i due inizi sono molto simili), ma molto rapidamente rivela una profonda individualità. Nelle parole dell’autore: “Avevo in testa questa idea di ‘imparentare’ un mio pezzo con questo lied da una decina d’anni circa e proprio ora si è finalmente concretizzata l’occasione adatta per farlo. L’estetica dell’objet trouvé è un altro tema a me caro e caro alla musica che da ascoltatore seguo con più interesse; trovo permetta di creare musica autonoma ex-novo sfruttando un processo di derivazione ‘naturale’ in fondo non molto diverso dalla generazione di un nuovo individuo che mutua il tuo patrimonio genetico senza per questo negare il suo status di nuovo individuo”.
La terzina, ad esempio, figura ritmica cruciale nel lied di Schubert, è affidata di volta in volta – non sempre per intero, peraltro – alla fisarmonica, al violino o al violoncello, o, addirittura, a diverse combinazioni dei tre. I temi, che nell’originale sono naturalmente affidati alla voce, vengono qui gestiti in maniera più dinamica: talvolta è il violino a condurre il discorso, altre volte il violoncello, altre ancora la fisarmonica sostiene gli altri strumenti e interloquisce con essi. Sempre affidandoci alle parole di Ventimiglia: “I ‘bei giochi’ promessi da quest’ultimo [l’Erlkönig n.d.r.] sono quelli che mi ha dato piacere fare con gli elementi appena menzionati, tanto localmente, quanto globalmente, permettendomi di avere appunto un DNA da cui far germogliare l’intera composizione: un organismo musicale il cui forte legame biologico col ‘genitore’ non ne inibisce l’affermarsi come ‘individuo’ a sé”.
Di fatto, ascoltando il brano di Ventimiglia è evidente l’autonomia sostanziale del suo brano dal “genitore” metaforico schubertiano. Lo si sente poco dopo l’inizio: il ritmo di terzina, con un andamento melodico che sembra derivare anch’esso dal lied originale, diventa materiale per una sezione quasi minimalista (e qui è difficile non riscontrare una certa “parentela” con la musica di Philip Glass che Ventimiglia riconosce come fonte di ispirazione).
 Quando Roberto Ventimiglia dice che “Avevo in testa questa idea di ‘imparentare’ un mio pezzo con questo lied da una decina d’anni circa […]” sta comunicando un particolare rapporto con la musica, che sia essa ascoltata o scritta: il bisogno profondo di intessere con essa un legame fisico in qualche modo. In effetti, come dice lui stesso: “[…] la musica, dovessi dare la mia personale definizione, è una risposta a questi bisogni interiori che possiamo avvertire […]”.
Quando Roberto Ventimiglia dice che “Avevo in testa questa idea di ‘imparentare’ un mio pezzo con questo lied da una decina d’anni circa […]” sta comunicando un particolare rapporto con la musica, che sia essa ascoltata o scritta: il bisogno profondo di intessere con essa un legame fisico in qualche modo. In effetti, come dice lui stesso: “[…] la musica, dovessi dare la mia personale definizione, è una risposta a questi bisogni interiori che possiamo avvertire […]”.
Rispetto all’uso della fisarmonica, il compositore non è alla sua prima esperienza: nel 2013, infatti, aveva scritto una raccolta di studi per le prime fasi dello studio della fisarmonica (edita da Bèrben) dal titolo Quando il gioco si fa musica… si comincia a suonare!. Per me è particolarmente emozionante ricordare che ho avuto la possibilità di eseguire alcuni di quegli studi durante la presentazione della raccolta al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, come se nel percorso di Roberto con la fisarmonica ci fosse un po’ anche del mio percorso di strumentista. Le possibilità offerte dalla fisarmonica, nel senso timbrico e sonoro in generale, hanno dato un grande spunto a Ventimiglia, allora come oggi, per lavorare con la fisarmonica. Per fare solamente un esempio: “Le possibilità che oserei definire ‘ultraterrene’ dell’estremo registro grave hanno saputo stuzzicare e soddisfare la mia immaginazione proprio come desideravo”. Anche la questione dei registri è stata di grande interesse per Ventimiglia: “I registri, le possibilità che ti offrono di espandere lo spettro d’azione acustico in più direzioni sono stati e restano oggi il primo motivo di interesse se penso alla possibilità di impiegare la fisarmonica nel mio lavoro”.
Quando gli ho chiesto di provare a dare un consiglio ad un giovane compositore che voglia sfruttare le possibilità della fisarmonica, Roberto non ha avuto dubbi: “[…] lavorare a stretto contatto con uno strumentista e giovarsi del rapporto assiduo e costante che questi intrattiene con il suo strumento. Il punto di vista di chi suona uno strumento che potrebbe non far parte del nostro quotidiano o della nostra eventuale pratica strumentale è davvero fondamentale, la chiave di tutto oserei dire”. Questa umiltà di fronte alla musica, multiforme e forse mai veramente conoscibile, è un tratto molto evidente ed estremamente appagante del lavorare con Roberto Ventimiglia, e i frutti di questo approccio si vedono chiaramente anche in quest’ultimo brano.
In conclusione, speriamo che Roberto Ventimiglia continui a scrivere, in particolare per fisarmonica, e che contribuisca ancora alla nascita di nuovi brani per e con questo strumento così speciale, che con il progetto Accordion Waves suona italiano sta trovando sempre più compositori interessati e incuriositi.
ACCORDION WAVES suona italiano
Roberto Ventimiglia – Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir – trio per violino, violoncello e fisarmonica