Testimone in diretta
Carl Ditters von Dittersdorf, “Autobiografia” (a cura di Marco Murara)
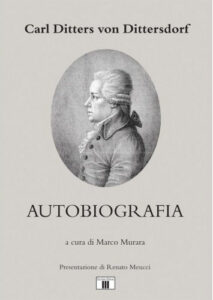 Compositore molto ammirato dai propri contemporanei, Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799) fu presto dimenticato dopo la morte. A rendergli il giusto tributo arriva in libreria la sua Autobiografia, pubblicata dall’editore Zecchini. Il testo rivela un uomo dotato di una forte personalità e di un carattere svincolato da molte convenzioni, cosciente del proprio status di musicista, che inizia ad affrancarsi dalla “sudditanza” nei confronti del potere laico ed ecclesiastico. Di Dittersdorf e del suo racconto di vita e di musica – spesso graffiante e smaliziato – ho parlato con Marco Murara, notaio e cultore della musica del ‘700, che lo ha curato e tradotto dal tedesco.
Compositore molto ammirato dai propri contemporanei, Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799) fu presto dimenticato dopo la morte. A rendergli il giusto tributo arriva in libreria la sua Autobiografia, pubblicata dall’editore Zecchini. Il testo rivela un uomo dotato di una forte personalità e di un carattere svincolato da molte convenzioni, cosciente del proprio status di musicista, che inizia ad affrancarsi dalla “sudditanza” nei confronti del potere laico ed ecclesiastico. Di Dittersdorf e del suo racconto di vita e di musica – spesso graffiante e smaliziato – ho parlato con Marco Murara, notaio e cultore della musica del ‘700, che lo ha curato e tradotto dal tedesco.
Notaio Murara, vorrei, innanzitutto, che mi raccontasse da dove nasce questa sua passione per la riproposizione di documenti e opere a carattere biografico e autobiografico di musicisti. E, anche, che spiegasse ai nostri lettori meno “addetti ai lavori” in che cosa consiste la curatela di questi scritti.
La mia passione per la riproposizione di documenti biografici e autobiografici di musicisti nasce dalla mia predilezione per la musica del Settecento e da una semplice convinzione: dietro a ogni composizione c’è sempre un essere umano, con le sue esperienze, le sue fragilità, le sue scelte. Le opere musicali parlano da sole, ma le parole dei compositori e quelle dei loro contemporanei ci permettono di entrare in un contesto storico e personale che arricchisce enormemente l’ascolto e la comprensione della musica. In un’epoca in cui tendiamo a consumare la musica in modo veloce e frammentato, credo sia prezioso restituire anche le voci, i racconti, le prospettive dei protagonisti attraverso i documenti coevi.
Per quanto riguarda la curatela, si tratta di un lavoro duplice. Da un lato c’è la traduzione, che richiede fedeltà al testo originale ma anche la capacità di renderlo scorrevole e naturale per il lettore contemporaneo. Non bisogna dimenticare che si traduce non solo una lingua, ma anche un’epoca, con le sue sfumature culturali. Dall’altro lato c’è il lavoro di mediazione: introdurre, annotare, spiegare i riferimenti storici o musicali che oggi non sono immediatamente evidenti. Il curatore diventa così una sorta di ponte che permette a un testo nato nel Settecento di dialogare direttamente con un lettore del XXI secolo.
Carl Ditters von Dittersdorf non è certo tra i più celebri musicisti dell’epoca classica. Quale fu il suo contributo alla ricerca musicale (e del teatro musicale) del proprio tempo?
È vero, oggi Dittersdorf non gode della stessa fama di Mozart, Haydn o Gluck, ma se fosse possibile porre la domanda a un musicofilo viennese di fine Settecento, la risposta sarebbe ben diversa: Dittersdorf ottenne infatti in vita una grande notorietà, che tuttavia conobbe un rapido declino dopo la sua morte. Il suo contributo allo sviluppo della musica fu tutt’altro che marginale. Anzitutto come violinista e direttore, egli incarnò una figura di musicista estremamente versatile, capace di muoversi con disinvoltura tra la corte aristocratica e la tradizione popolare. Sul piano della ricerca musicale, Dittersdorf fu particolarmente significativo nel campo del Singspiel di lingua tedesca, dove seppe combinare la leggerezza del gusto popolare con una scrittura orchestrale ricca e raffinata. Non va dimenticato, inoltre, che come sinfonista egli contribuì a diffondere e consolidare il modello haydniano, producendo quasi centotrenta sinfonie, oltre a numerose altre composizioni strumentali, che circolarono ampiamente in Europa. Un esempio eloquente sono le sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio, nelle quali egli fuse immagini mitologiche ed elaborazione musicale in maniera vivace e coinvolgente. In sintesi, pur non avendo rivoluzionato il linguaggio musicale come Mozart o Beethoven, Dittersdorf svolse un ruolo importante nel rendere tale linguaggio comprensibile e amato da un pubblico più ampio. E questo, credo, è un merito che lo rende ancora oggi degno di attenzione.
L’autobiografia di von Dittersdorf, oltre a essere un’utile fonte storica, mette in luce anche aspetti che potremmo definire “economici e sociologici”. Mi riferisco, soprattutto, alla posizione del musicista nella società del XVIII secolo. Dalla totale subalternità al potere politico ed ecclesiastico al delinearsi di un nuovo ruolo, che emergerà nella sua pienezza solamente con Beethoven…
È un’osservazione molto pertinente, e che tocca uno degli aspetti più affascinanti della Lebensbeschreibung. Leggendo l’autobiografia, ci si accorge che Dittersdorf non parla soltanto di musica, ma della propria condizione di musicista immerso in una rete di rapporti di potere, dipendenze economiche e aspettative sociali. È, per così dire, un “testimone in diretta” di quel passaggio in cui l’artista era ancora funzionario di corte o servitore di un principe vescovo, ma già iniziava ad affacciarsi l’idea di un’autonomia professionale.
Il racconto di Dittersdorf – spesso ironico, talvolta disincantato, mai pedante – lascia anche intravedere una coscienza nuova, quella di un compositore consapevole del proprio valore e dell’importanza del proprio ruolo. D’altronde, nei rapporti con i suoi datori di lavoro, in particolare con il vescovo di Breslavia, alle dipendenze del quale lavorò per quasi venticinque anni, Dittersdorf rivendicò e ottenne il diritto a figurare tra i più stretti consiglieri del principe. Emblematica, sotto questo profilo, è l’elevazione al rango nobiliare che gli fu conferita nel 1773.
È vero che la piena affermazione di questo nuovo ruolo avverrà solo con Beethoven, simbolo dell’artista libero e indipendente. Ma proprio perché Dittersdorf non raggiunse quella condizione, terminando anzi i suoi giorni nell’indigenza, la sua autobiografia ci restituisce la dimensione concreta di chi visse in mezzo a quel cambiamento epocale. Ed è anche questo che rende il testo straordinariamente vivo e interessante per i lettori di oggi.
Perché la musica di Carl Ditters von Dittersdorf è stata pressoché dimenticata e quali ne sono, oggi, gli interpreti più interessanti? Tra l’altro, anche in rete è difficile trovarne delle esecuzioni…
Dittersdorf è stato un autore di grande successo in vita, ma il suo destino postumo è stato segnato da alcuni fattori. La sua produzione vastissima – sinfonie, opere teatrali, musica sacra, concerti – ha risentito di una qualità non sempre uniforme: accanto a pagine ispirate ci sono lavori più convenzionali, scritti per una rapida fruizione presso la corte o la chiesa. Questo ha favorito la selezione, da parte della storia, dei soli nomi che hanno incarnato con forza un linguaggio riconoscibile e innovativo, come Haydn, Mozart o Beethoven. Molte partiture di Dittersdorf, inoltre, sono andate perdute o giacciono ancora manoscritte negli archivi, circostanza che ha limitato la circolazione della sua musica. Infine, la nascita del “canone classico” nell’Ottocento ha contribuito a metterlo in ombra: in un panorama dominato da figure considerate geniali e rivoluzionarie, Dittersdorf è rimasto classificato come autore “minore”.
Negli ultimi decenni, però, si è assistito a un lento recupero. Penso, ad esempio, alla godibile interpretazione del Singspiel Doktor und Apotheker diretta da James Lockhart con la Staatsorchester Rheinische Philharmonie (1995) o alle varie registrazioni delle sinfonie delle Metamorfosi, tra la recente (2024) di Case Scaglione con la Württembergisches Kammerorchester Heilbronn. È vero che in rete le esecuzioni di sue composizioni sono rare, ma questo dipende dal fatto che Dittersdorf non appartiene al cosiddetto “repertorio stabile”: le incisioni ci sono, spesso di grande qualità, ma restano per lo più di nicchia. Ed è proprio per questo che credo sia importante, oggi, tornare a proporlo: non solo come curiosità storica, ma come voce originale di un’epoca che ha prodotto molto più della consueta ”triade” del classicismo viennese.
Marco Murara, notaio, cultore di storia della musica del Settecento, ha pubblicato: Mozart. Tutti i testi delle composizioni vocali (2004, in collaborazione con Bruno Bianco), raccolta di tutti i testi messi in musica da Mozart, accompagnati da traduzioni originali, commenti e numerosi indici; Tutte le lettere di Mozart (2011, 2a ed. 2020), l’epistolario completo della famiglia Mozart dal 1755 al 1791, per la prima volta tradotto in italiano nella sua completezza e annotato; la traduzione italiana della Biographie W.A. Mozart’s di Georg Nikolaus Nissen (2018); Mozart. Le cronache (2021), monumentale raccolta di oltre duemila documenti risalenti al periodo 1756-1792 che si riferiscono a Mozart o alle sue composizioni, tradotti in italiano e corredati da un corposo apparato di note.
Carl Ditters von Dittersdorf, Autobiografia (a cura di Marco Murara)
Editore: Zecchini, Varese
Anno di edizione: 2025
Pagine: 250, brossura, € 33,00
© RIPRODUZIONE RISERVATA

