Respirare il dolore
Dina Tullio Donatone, Jairo Enrique Gallo Acosta, “Musica e desiderio. La sfida dell'ascolto come atto creativo tra suono e psicoanalisi”
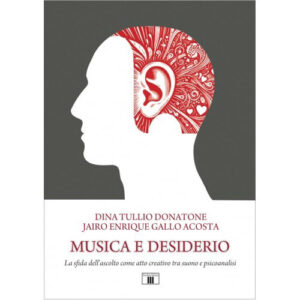 Questo libro non l’ho solamente letto, ma ascoltato. E percepito anche con altri sensi, a cominciare dal tatto. È un testo, scritto a quattro mani da una musicista e uno psicanalista lacaniano, che va “assorbito” gradualmente, come se si ascoltasse un brano musicale e come se avessimo cosparso i nostri corpi con un unguento incredibilmente salutare. Leggendo l’intervista ne capirete il perché. Poi, dovrete assaporare l’intero libro per riceverne tutta la potenza sinestetica di cui ho goduto io…
Questo libro non l’ho solamente letto, ma ascoltato. E percepito anche con altri sensi, a cominciare dal tatto. È un testo, scritto a quattro mani da una musicista e uno psicanalista lacaniano, che va “assorbito” gradualmente, come se si ascoltasse un brano musicale e come se avessimo cosparso i nostri corpi con un unguento incredibilmente salutare. Leggendo l’intervista ne capirete il perché. Poi, dovrete assaporare l’intero libro per riceverne tutta la potenza sinestetica di cui ho goduto io…
Le riflessioni, che ti hanno portato a concepire questo libro, hanno inizio con l’ascolto di Stringeranno nei pugni una cometa di Silvia Colasanti. Come nasce questo Requiem e che cosa ha fatto maturare (direi “scatenare”) in te?
L’ascolto di Stringeranno nei pugni una cometa ha rappresentato per me un varco, qualcosa da vivere e attraversare. Non è stato semplicemente l’incontro con una composizione contemporanea, ma un’esperienza nuova. Quando pensiamo a un Requiem, lo associamo a una forma rituale della memoria e della pietà: una commemorazione affidata a un linguaggio solenne e corale. È una musica che elabora la perdita dentro un quadro condiviso, che offre una sorta di riparo simbolico: un luogo in cui il dolore può essere riconosciuto e accompagnato. Il Requiem di Silvia Colasanti, invece, rinuncia a quel riparo. Non dispone il dolore dentro una forma già data: lo lascia vibrare nella sua materia viva. Qui il dolore diventa un’urgenza: non quella di raccontarlo o spiegarlo, ma di lasciarlo vivere. E allora il dolore non è più contemplato da lontano: è respirato, chiede di passare attraverso chi ascolta. E nel farlo, riapre la domanda sulla perdita: non solo quella dei nostri cari, ma anche quella parte di noi che, nella vita quotidiana, sembra smarrirsi, disperdersi in un tempo che livella e uniforma, che distrae. È come se la musica dicesse: “Che cosa abbiamo perduto? Che cosa continuiamo a perdere?” E insieme: “Che cosa, nonostante tutto, resta vivo?”. Ascoltando la composizione ho sentito che quella musica chiedeva di essere accolta. E da lì è nata la domanda che ha dato origine al libro: come si ascolta ciò che chiede di lasciarsi attraversare? Quella domanda ha continuato a risuonare in me. È stata l’inizio del cammino che mi ha portato a scrivere.
L’incipit del libro, però, denuncia anche “una sensazione di mancanza” all’origine del libro: la capacità di ascoltare…
Sì, all’origine del libro c’è una sensazione di mancanza. Non una mancanza da colmare, ma una condizione da riconoscere: qualcosa che precede l’ascolto e lo rende possibile. La sensazione è nata anche da una domanda che mi accompagna da tempo: perché è così difficile, oggi, accostarsi alla musica colta contemporanea? Non si tratta solo di una questione di linguaggi o di abitudini, ma di ascolto: spesso arriviamo alla musica con l’idea di dover comprendere, riconoscere e, forse, anche dominare ciò che ascoltiamo. E quando questo non accade, subentra lo smarrimento. Penso che questa difficoltà non riguardi soltanto la musica, ma il modo in cui ascoltiamo noi stessi. Se non siamo più in contatto con il nostro spazio interno, con quella zona di disponibilità che permette alle cose di risuonare, anche la musica che non offre appigli immediati ci appare distante, indecifrabile. È come se la musica ci domandasse un luogo in cui poter risuonare, e noi non sempre sapessimo riconoscerlo. La difficoltà non è fuori, nella musica, ma nella disponibilità di quel luogo interno. Da qui la riflessione che la mancanza è la stessa: mancanza di ascolto della musica e mancanza di ascolto di sé. Siamo soliti pensare l’ascolto come un atto rivolto verso l’esterno, un accogliere un suono, una voce. In realtà, l’ascolto riguarda anche ciò che non si sente: riguarda uno spazio interiore, un vuoto che chiede di essere abitato. Ascoltare significa accettare che non possediamo il senso in anticipo. Il senso non si deduce: accade. E perché questo accadere sia possibile è necessario un luogo interno in cui qualcosa possa risuonare e trasformarsi. Quella mancanza è questo luogo: un punto di disponibilità. Viviamo spesso cercando di colmare ogni intervallo, di saturare il tempo e il pensiero. Ma senza vuoto non c’è risonanza; senza attesa non c’è incontro. La mancanza ci restituisce una porosità. È ciò che ci espone alla musica, all’altro, al mondo — e anche a noi stessi. In questo senso, la mancanza è già ascolto. È la condizione da cui tutto prende forma.
Si può ascoltare il silenzio?
Sì, si può ascoltare il silenzio. Ma non come assenza. Il silenzio non è un vuoto muto: è uno spazio vivo, in cui ciò che abbiamo ascoltato continua a risuonare. Spesso si confonde il silenzio con la pausa. La pausa è scritta nella musica: ha una durata, un valore, una misura. È inscritta nella partitura, è codificata, in altre parole, si può contare. Il silenzio, invece, non si misura, non ha una forma stabilita. Non è un “momento senza suono”, ma un campo di possibilità. Il silenzio è ciò che permette al suono di accadere e di depositarsi. È la condizione che dà profondità all’ascolto, come l’ombra dà profondità alla luce. Nel silenzio non ascoltiamo ciò che viene dall’esterno, ma ciò che si muove dentro di noi dopo l’ascolto. Si ascolta il silenzio quando non si tenta di colmarlo, quando ci si lascia raggiungere da ciò che il suono ha smosso, dalla domanda che ha aperto, dalla memoria che ha risvegliato. Ed è vero che oggi facciamo più fatica ad ascoltarlo. Non perché il silenzio sia scomparso, ma perché è diventato più difficile rimanere in quella zona di attesa, di sospensione, di non-immediato. Viviamo in un tempo che tende a riempire, a produrre senso in fretta. Il silenzio, invece, chiede disponibilità. È una forma di fiducia. Ascoltare il silenzio significa ascoltare la propria risonanza; significa restare in contatto con ciò che ancora non ha preso forma, con ciò che è lì, in attesa, con ciò che vibra nel non detto. In questo senso, il silenzio non è fine, ma prolungamento: è la parte della musica che continua in noi anche quando la musica non c’è più.
Una parte qualitativamente, anche se non quantitativamente, rilevante del libro è costituita dalle immagini. “Immagini che ascoltano”, le definisci. Che cosa significa?
Le immagini presenti nel libro non hanno una funzione illustrativa. Non servono a spiegare o a rendere visibile ciò che la musica non può dire. Dunque, non traducono e non commentano; sono, piuttosto, presenze. Ho scelto le fotografie di Massimo Botter proprio per questo: perché sono immagini che appartengono al nostro tempo, alla stessa contemporaneità che attraversa la musica di Colasanti. Non rimandano a un passato già sedimentato, né a un immaginario già condiviso. Non offrono un’interpretazione o un orientamento: restano aperte. Sono immagini che abitano il presente, come la musica che ascoltiamo e la domanda che essa solleva. Sono parte dello stesso “ora” in cui accade l’ascolto. Mi piace pensare che nel libro più voci sostino insieme: la voce della scrittura, quella del pensiero che lentamente si chiarisce, quella delle immagini e, in filigrana, la voce della musica. Non c’è gerarchia. Nessuna voce spiega l’altra, nessuna prevarica: semplicemente convivono. Per questo le definisco “immagini che ascoltano”. Perché non chiedono di essere guardate velocemente, né di essere interpretate subito. Invitano a rallentare, a entrare in un tempo più interno, più profondo, disposto all’accoglienza. Non propongono un significato, ma, ancora una volta, uno spazio: un luogo in cui sostare, come davanti a un suono che non si vuole lasciar dissolvere troppo presto. Sono immagini che non parlano sopra: si dispongono accanto. E invitano chi guarda a fare lo stesso.
Anche le immagini possono essere ascoltate?
Sì, le immagini possono essere ascoltate. Ma occorre capovolgere, anche solo per un istante, il modo in cui siamo abituati a guardare. Di fronte a un’immagine pensiamo spesso che il compito sia capire, riconoscere e quindi interpretare. Invece, quando un’immagine viene ascoltata, siamo noi a offrirle uno spazio e un tempo. Un’immagine può essere ascoltata quando la si lascia agire dentro di sé, senza forzarla a dire qualcosa subito: come quando si ascolta un accordo sospeso, una risonanza che non si vuole interrompere. In quel momento, ciò che vediamo e ciò che sentiamo non sono più separati. La percezione si fa interiore: qualcosa che abbiamo già incontrato in noi si ridesta, si orienta, muovendosi verso ciò che è già sedimentato nella nostra memoria sensibile. Ciò che l’immagine custodisce, allora, entra in movimento. E, in questo senso, l’immagine non è un oggetto da decifrare, ma un incontro. È un corpo che si offre a un altro corpo: non soltanto al nostro sguardo, ma anche alla nostra memoria e al nostro respiro. L’immagine non parla al pensiero, ma alla nostra materia viva. E lo fa senza rumore, come una presenza che resta e che insiste. Per questo dico che le immagini del libro possono essere ascoltate: perché chiedono di essere accolte con la stessa attenzione e la stessa delicatezza che riserviamo alla musica quando non pretendiamo di darle un senso, ma la lasciamo abitare dentro di noi.
Dina Tullio Donatone è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, laureata in Scienze della Formazione Primaria e ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in “Musica, Scienza e Tecnologia del Suono”. Si è perfezionata in pianoforte con il M° Pier Narciso Masi e ha vinto vari premi in concorsi pianistici e cameristici. Specializzata in biblioteconomia musicale, ha collaborato dal 2000 al 2007 con la Biblioteca del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Autrice di pubblicazioni in ambito musicale-psicologico, è docente di Bibliografia e Biblioteconomia musicale presso il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e, dal 2013, Ispettrice dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori e membro del Circolo Psicoanalitico Caraibico del Mediterraneo.
Jairo Gallo Acosta è psicologo e psicoanalista. Magister in Psicoanalisi presso l’Università Argentina John F. Kennedy. Dottore in Scienze Sociali e Umane presso la Pontificia Università Javeriana. Ha svolto un soggiorno post dottorale presso l’Università Michoacana di San Nicolás de Hidalgo. Professore e ricercatore presso l’Università Cooperativa della Colombia e l’Università Nazionale della Colombia e autore di numerosi saggi. È Membro del Circolo Psicoanalitico dei Caraibi.
Dina Tullio Donatone, Jairo Enrique Gallo Acosta, Musica e desiderio. La sfida dell’ascolto come atto creativo tra suono e psicoanalisi
Editore: Zecchini, Varese
Anno di edizione: 2025
Pagine: 104, Ill, brossura, € 25,00
ASCOLTA IL BRANO DI SILVIA COLASANTI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

